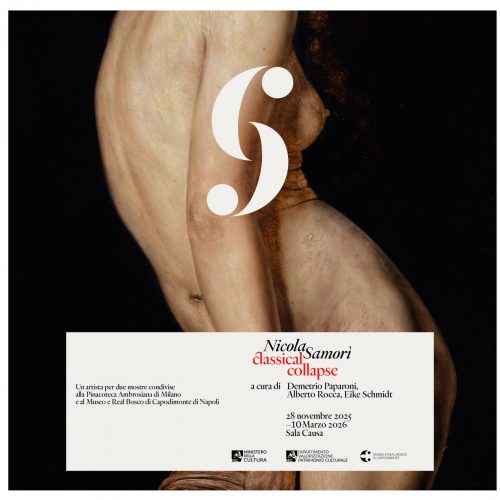L’Italia chiamò – Capodimonte oggi racconta… le raccolte di porcellane e maioliche del Museo e Real Bosco di Capodimonte
Con la rubrica L’Italia chiamò – Capodimonte oggi racconta… anche quest’anno il Museo e Real Bosco di Capodimonte partecipa alla manifestazione nazionale Buongiorno ceramica 2020, un’edizione digitale, per l’emergenza sanitaria in corso, che racconterà nel weekend le collezioni di ceramiche di Capodimonte e la Real Fabbrica di Porcellana.
Il primo dei due interventi, a cura di Maria Rosaria Sansone e Alessandra Zaccagnini, assistenti del Dipartimento Scientifico per le Arti decorative (Porcellane e Ceramiche), ci presenta le raccolte di porcellane e maioliche del Museo e Real Bosco di Capodimonte.
Il museo di Capodimonte conserva una collezione di porcellane fra le più importanti in Europa che, nel prossimo biennio, sarà oggetto di una importante e complessiva operazione di riallestimento e di valorizzazione.
Porcellane e terraglie possono e devono infatti essere considerate – all’interno del ricchissimo patrimonio del Museo e Real Bosco di Capodimonte – strettamente legate alla natura del sito.
Non solo, infatti, il nome Capodimonte è indissolubilmente unito a quello della manifattura di porcellana voluta e finanziata da Carlo di Borbone, ma anche a Capodimonte in epoca postunitaria vennero concentrate e riunificate le ricchissime raccolte ceramiche di provenienza borbonica sparse nei vari siti reali.
Esposte nei vari allestimenti dell’Otto e del Novecento solo in piccola parte, le porcellane e le terraglie verranno ora esibite al pubblico nella loro totalità, con un allestimento da “Cabinet” che ne esalterà, oltre che la qualità, il numero e la varietà.
Il numero e le varietà della raccolta (composta da oltre 6000 pezzi tra porcellane, biscuits, maioliche e terraglie) include oggetti delle più importanti manifatture italiane ed europee attive tra il XVIII e XIX secolo.
Il corpus principale del nucleo è costituito da oggetti di provenienza borbonica, radunati a Capodimonte a ridosso dell’Unità d’Italia (1861) dal cavaliere Annibale Sacco, direttore amministrativo della Casa Reale Savoia (1863-1887).
Sacco, come curatore e conservatore della reggia, concentrò a Capodimonte le ingenti raccolte ceramiche dei Borbone che si trovavano distribuite nei numerosi Siti Reali del Regno con destinazione d’uso e di arredo, con l’intento di esporle nel museo che andava costituendo.
Grazie all’attività di riordino di Annibale Sacco giunsero a Capodimonte anche oggetti e servizi in porcellana provenienti dalle residenze reali Savoia di Torino, Roma e Firenze che andarono a rafforzare notevolmente l’antico nucleo dei Borbone.
Di provenienza borbonica, il piccolo ma importantissimo gruppo della Real Fabbrica della porcellana di Capodimonte (1743-1759) di cui fanno parte il Corredo d’altare, in origine collocato nell’Oratorio Segreto di Sua Maestà nella Reggia di Portici, e il Bacile da barbiere a forma di conchiglia che mostra la decorazione di cui Gricci fu inventore e specialista, quella “a conchiglia di mare”.

In origine il corredo d’altare era collocato nel Palazzo Reale di Portici, e precisamente nell’Oratorio Segreto di Sua Maestà. Il corredo di committenza reale, risulta dagli inventari trasferito nel 1806 a Palermo per l’arrivo dei francesi a Napoli, e infine trasferito nel 1881 dal Palazzo Reale di Caserta a Capodimonte grazie all’accorpamento delle collezioni ceramiche borboniche intrapresa da Annibale Sacco. L’apparato sacro presenta delle caratteristiche stilistiche e del modellato che lo riconducono all’intagliatore Gaetano Fumo, attivo nella fabbrica reale proprio dal 1745.

Il bacile – realizzato dal capo-modellatore della fabbrica Giuseppe Gricci – riprende la forma della valva di una conchiglia tropicale, decorata a sua volta da incrostazioni marine. La forma della coppa diventa elaboratamente fantasiosa e rocaille nell’andamento del bordo ondulato e curvilineo, concludendosi con un ricciolo che funge da presa. Questo straordinario pezzo racchiude e coniuga insieme gusto rococò e -probabilmente – studio e derivazione diretta dalla natura.
Nel 1866 venne inoltre trasferito e rimontato a Capodimonte da Portici il Salottino di porcellana della regina Maria Amalia.

Realizzato tra il 1757 ed il 1759 per la regina di Napoli su progetto dello scenografo piacentino Giovan Battista Natali, il piccolo boudoir con scene di vita cinese era destinato alla Reggia di Portici; nel 1866 fu trasferito da Annibale Sacco nella Reggia di Capodimonte. Il decoro a chinoiserie invade tutto lo spazio del salottino con animali esotici, frutta, festoni floreali, libri e cartigli, alcuni dei quali riportano in cinese motti di elogio del sovrano, altri invece imitazioni degli ideogrammi cinesi. Grandi specchiere affiancate da candelieri a tre luci completano le pareti. Infine al centro del soffitto pende un lampadario a dodici bracci, costituito da un fusto a forma di palma su cui si arrampica una scimmia e accanto alla quale siede un giovane cinese che pungola con il suo ventaglio un drago.
A integrazione degli oggetti prelevati dai vari siti reali borbonici seguì una scrupolosa politica di acquisizioni intrapresa da Sacco fin dagli anni Settanta dell’Ottocento, motivata dall’intento di accrescere il nucleo dei manufatti di committenza borbonica, con particolare attenzione per la produzione carolina.
Di provenienza borbonica è anche una cospicua raccolta di porcellane e biscuits della Real Fabbrica della porcellana di Napoli (1771-1806), fondata da Ferdinando IV di Borbone.
Il nucleo ben rappresenta l’intero arco della produzione della manifattura reale: dagli imponenti serviti da tavola come il Servizio con le vedute del Regno, detto dell’Oca, ai numerosi biscuits che rappresentano personaggi dell’antichità e soggetti mitologici; dalle figure singole ai gruppi, come la spettacolare Caduta dei Giganti, il più grande biscuit oggi noto.
Il gusto per l’antico, profondamente radicato a Napoli grazie agli scavi di Ercolano e Pompei, fu determinante in tutti i vari ambiti culturali ed artistici, e specialmente nella produzione delle porcellane di Napoli.
Sotto la direzione artistica di Domenico Venuti (dal 1779), figlio e nipote di archeologi, si introdusse nella fabbrica un profondo cambiamento di gusto e di cultura in senso neoclassico.

celebrativo del regno borbonico, della sua vastità e delle sue bellezze naturali che attiravano i viaggiatori stranieri.

È parte del servizio delle Vedute napoletane, detto dell’oca dai pomi di alcuni coperchi, recanti un putto che strozza un’oca, tratto da un modello ellenistico conservato ai Musei Capitolini. Il grande servizio da tavola è costituito da spettacolari vedute del Regno in linea sia con il vedutismo pittorico, molto in voga, che anche con un chiaro intento
celebrativo del regno borbonico, della sua vastità e delle sue bellezze naturali che attiravano i viaggiatori stranieri.

Il centrotavola con il carro del Sole e le dodici Ore che accompagnano l’Aurora, iniziato nella fabbrica reale di Ferdinando IV, venne ultimato con felice continuità di soluzione durante il decennio francese da Giovanni Poulard Prad, che rilevò dai napoleonidi la privativa della fabbrica. La notevole composizione in biscuit è un omaggio alla nuova regina di Napoli Carolina Murat, rappresentata nelle vesti di Venere seduta su di un carro trainato da due cavalli, e preceduta
dalla figura dell’Aurora accompagnata dal corteo delle figure delle dodici Ore e da nove putti che simboleggiano i vari tipi di amore. La Venere al centro è inquadrata da una ricca ghirlanda di fiori e foglie, sorretta dalle figure che circondano la dea, impegnate in un corteo che sembra quasi una danza.

La forma piramidale e l’ardito posizionamento dei corpi nello spazio fanno di questo trionfo il più complesso lavoro del capo-modellatore della fabbrica Filippo Tagliolini, che in questa monumentale composizione, colossale e al tempo stesso elegante, riuscì a rendere ben evidente la sua formazione accademica e la sua grande conoscenza dell’anatomia umana, donando un grande senso di plasticità scultorea. Il gruppo era destinato ad essere utilizzato come “trionfo da tavola” in occasione dei grandi banchetti della corte.

Il modello di Filippo Tagliolini riprende il tema desunto da una pittura murale rinvenuta a Resina nel 1739. Questo gruppo testimonia l’abilità di Tagliolini di utilizzare i modelli antichi nella produzione plastica in biscuit della manifattura reale. Inoltre, la ripresa dei temi archeologici diventa un mezzo di ostentazione del patrimonio artistico del Regno e, di conseguenza, della sua grandezza. Nell’inventario di cessione della manifattura del 1807 sono indicati ben sei esemplari di questo gruppo in biscuit, a testimonianza del fatto che il modello fu più volte replicato nella Real Fabbrica di Napoli.
Di provenienza reale, murattiana e borbonica, il museo conserva porcellane della Manifattura Poulard Prad (1806-1815), nata dalla cessione della privativa della Real Fabbrica di Napoli all’imprenditore Giovanni Poulard Prad durante il decennio francese, come i quattro importanti busti in biscuit con i ritratti all’antica di Gioacchino Murat, Carolina Bonaparte e dei figli Achille e Letizia.
Il periodo successivo alla Restaurazione, dopo il 1815, è caratterizzato dall’utilizzo di porcellane bianche prodotte in Francia, che venivano poi decorate a Napoli da un gruppo di raffinati miniatori, primo fra i quali Raffaele Giovine (attivo dal 1820 al 1866).


Il déjeuner fu commissionato da Francesco I – al tempo ancora duca di Calabria – per farne dono al padre Ferdinando IV, ed è decorato con i ritratti della famiglia reale accompagnati da versi commemorativi. Il plateau presenta, oltre alla scritta dedicatoria, la spettacolare eruzione del Vesuvio del 1822. Il tema riprendeva pienamente gli interessi e il gusto del tempo rivolti allo studio e alla conoscenza degli avvenimenti naturali e spettacolari come le eruzioni vulcaniche. Sulla falsariga degli studi compiuti dall’ambasciatore inglese a Napoli Sir William Hamilton, e della sua pubblicazione dei Campi Phlegraei. Observation on the Volcanos of the Two Sicilies ( 1776), con tavole di Pietro Fabris, le eruzioni del Vesuvio, già “genere” pittorico in voga dalla fine del Settecento, erano diventate una attrattiva turistica e culturale
È purtroppo esiguo il gruppo di porcellane borboniche di Meissen, la prima manifattura di porcellana ad essere avviata in Europa (dal 1710 ad oggi), nonostante sappiamo che la regina Maria Amalia di Sassonia (1724-1760), moglie di re Carlo di Borbone, portò in dote a Napoli numerosi oggetti della manifattura Sassone che molto impressionarono il giovane sposo.
Da un punto di vista numerico e quantitativo, di primaria importanza è il nucleo di porcellane della Manifattura Imperiale di Vienna, secondo solo a quello della Real Fabbrica di Napoli.
Una così cospicua presenza di oggetti nelle collezioni reali, in gran parte individuati negli antichi inventari borbonici, rilevante anche da un punto di vista qualitativo, è dovuta ai legami di parentela tra i regnanti di casa Borbone e gli Asburgo.
La regina Maria Carolina (1752-1814), moglie di Ferdinando IV di Borbone, è figlia dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria, e la sua primogenita Maria Teresa sposerà nel 1790 l’arciduca Francesco, futuro imperatore del Sacro Romano Impero.
Déjeuners e solitaires, cioè servizi per più persone o per una sola, decorati con vedute delle città di Vienna e Napoli e con i ritratti in silhouettes delle famiglie reali Borbone ed Asburgo, erano spesso doni inviati al re Ferdinando IV dalla regina Maria Carolina durante i sui soggiorni a Vienna (tra il 1800 e il 1801).

Gli oggetti fanno parte di un grande déjeuner decorato con vedute di Napoli e di Vienna e con ritratti in silouhettes dei personaggi delle due famiglie regnanti. Il servizio venne inviato a Napoli dalla regina Maria Carolina d’Austria come dono per il marito Ferdinando di Borbone durante il suo soggiorno a Vienna del 1800-1802.

Il solitaire, destinato all’uso personale del re Ferdinando IV, è provvisto del suo cofanetto in cuoio decorato con gigli dorati impressi. Questi emblemi araldici, assieme alla corona e al profilo del re en camaieu che compaiono su tazza e vassoio confermano la destinazione reale. Il servito, probabilmente commissionato dalla moglie Maria Carolina d’Asburgo, è caratterizzato da un effetto marmorizzato che ben testimonia le nuove tendenze di gusto che circolavano nelle maggiori manifatture europee. La porcellana che finge di essere marmo o altri materiali, in linea con il gusto neoclassico, aprirà la strada a diverse sperimentazioni tecniche in tal senso.
Anche gli oggetti della Manifattura Reale di Berlino (1752-1918) e di quella di Sèvres (dal 1740 ad oggi) sono in gran parte costituiti da doni inviati ai re di Napoli.

Il grande cratere è decorato ampiamente con ghirlande, fiori, frutta ed elementi vegetali realizzati con smalti policromi su un fondo color crema. Sono rappresentati grappoli d’uva e varie specie floreali tra cui iris, glicini, viole e dalie; una corona di edera percorre tutto il collo del cratere. Il resto della decorazione è completato da motivi a palmette spiraliformi o arabescati dipinti in oro matto e lucido. Fin dal 1815 la manifattura berlinese si distinse nella realizzazione di decori floreali che venivano desunti direttamente dai repertori a stampa di studi botanici.


Questo piatto, decorato con un mazzo di rose e con bordo in bleu lapis arricchito da fregi dorati, faceva parte di un servizio da dessert (oggi in gran parte disperso) donato nel 1836 a Ferdinando II, in visita alla manifattura di Sèvres, da Luigi Filippo. Dello stesso servizio fa parte anche un centrotavola – denominato corbeille palmier – composto da una cesta amovibile sorretta da foglie di palma lumeggiate in oro, la cui base è arricchita da quattro
putti in biscuit che mangiano datteri seduti su delle foglie di acanto dorate.
Di prestigiosa provenienza sono anche diversi grandi vasi della Manifattura Dagoty di Parigi (1800-1820) destinati da Napoleone per l’arredo del palazzo del Quirinale a Roma e recuperati nel 1814 da Gioacchino Murat per abbellire le regge napoletane.
Sono infine presenti anche i jasperware della Manifattura inglese di Josiah Wedgwood (1730-1795), particolari e durissimi grès colorati ad impasto sui quali spiccavano figure in rilievo ispirate all’Antico.
Infine, alle porcellane si affianca il considerevole gruppo dalle terraglie “all’uso inglese” – così definite perché imitanti i prodotti della manifattura di Wedgwood citata poc’anzi – costituito da circa 600 pezzi che comprendono prevalentemente oggetti realizzati dalle manifatture napoletane delle famiglie Del Vecchio e Giustiniani.
Le privative e le sovvenzioni economiche della Casa Reale ottenute da queste manifatture a partire dalla fine del Settecento si riflettono nel ricco nucleo del museo, prevalentemente grandi serviti da tavola e da caffè commissionati dalla corte borbonica per i vari siti reali, sino ad oggi esposti solo in piccola parte.

Lo stile “all’antica” si diffuse ampiamente nel Regno delle Due Sicilie, anche grazie agli straordinari reperti degli scavi archeologici di Pompei ed Ercolano. La manifattura di terraglie della famiglia Giustiniani si distinse in questo campo sia nell’imitazione che nella rielaborazione dell’Antico, desunti fedelmente dalla produzione vascolare classica nei decori, nel repertorio figurativo e nelle forme stesse del vasellame. Nel campo della porcellana, il decoro di gusto archeologico si era avviato grazie all’inglese Josiah Wedgwood che con la sua manifattura “Etruria” – fondata alla fine degli anni Sessanta del Settecento – aveva, fra i primi, adattato su grès, porcellane e terraglie modelli e forme desunti dall’Antico.

I vasi ad urna in terraglia marmorizzata si caratterizzano per il motivo decorativo delle anse che copia la grande scultura
dell’Ercole Farnese oggi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. L’ effetto marmorizzato, specialità dei Del Vecchio, era ottenuto aggiungendo all’impasto ceramico sostanze bituminose del Vesuvio che, conferendo striature e screziature, imitavano l’alabastro cotognino e le sue calde tonalità calde di terra.
Oltre ai nuclei di provenienza borbonica, grazie all’attività di riordino di Annibale Sacco di cui si è detto, a Capodimonte arriva il vasellame da tavola di casa Savoia, commissionato dai sovrani sabaudi dopo l’Unità di Italia per dotare le varie regge di adeguati serviti da utilizzare per le occasioni di rappresentanza.
Il Museo di Capodimonte conserva di questi un cospicuo patrimonio, con serviti, spesso ornati della corona reale, commissionati alle manifatture di Meissen, Berlino e Ginori e ricchissimi per numero, varietà, tipologia di forme.


Nel servizio di piatti con ‘vedute miniate a fascia blu’, composto da 366 pezzi, sono rappresentate entro riserve vedute panoramiche delle città di Napoli, Roma e Firenze e i siti archeologici del Regno delle Due Sicilie. Le stesse vedute ricorrono più volte con piccole varianti su piatti di diverse forme e dimensioni, talvolta identificate da una scritta sul retro. L’aspetto di questo tipo di porcellana, detta ‘masso bastardo’, prodotta dalla fabbrica di Doccia dal 1765, si presenta più opaco per l’utilizzo dello stagno al posto del piombo nel processo di ‘smaltatura’. Il servizio giunse a Napoli
dal 1892 insieme ad altre porcellane dalle residenze Savoia di Roma, Firenze e Torino, e venne commissionato nel 1814 alla manifattura Ginori da Elisa Baciocchi Bonaparte. Il re Ferdinando IV visitò Doccia nel 1785 ammirando le capacità
imprenditoriali della famiglia Ginori ed instaurò con la manifattura un intenso rapporto di scambi commerciali.
Accanto alle porcellane e alle terraglie sono da menzionare le maioliche custodite nel museo e fra queste, in primo luogo, il pregevole servizio di piatti in maiolica blu a fondo oro delle Officine di Castelli, databile alla seconda metà del XVI secolo, realizzato per il cardinale Alessandro Farnese, ed acquisito da Carlo di Borbone assieme alla raccolta Farnese.

Fa parte di un servizio da tavola di oltre centocinquanta pezzi, noto come “turchine”, a smalto blu, con al centro lo stemma in oro del cardinale Alessandro Farnese. Fu eseguito tra il 1574 e il 1589.
Infine sono da ricordare le maioliche rinascimentali e barocche donate a Capodimonte dal collezionista Mario De Ciccio nel 1957 assieme ad una vasta ed eclettica raccolta di oggetti.

Questo rinfrescatoio è parte di un servizio eseguito per i della Rovere; a tre anse leonine è riccamente decorato a grottesche e presenta al centro della vasca una scena di Congiario romano, tratta da una incisione del pittore manierista
Taddeo Zuccari.
Il testo di Maria Rosaria Sansone e Alessandra Zaccagnini è inserito nell’iniziativa “L’Italia chiamò – Capodimonte oggi racconta”
Leggi tutti gli articoli della rubrica
Leggi tutti gli articoli sul blog
Segui gli aggiornamenti sui nostri canali social